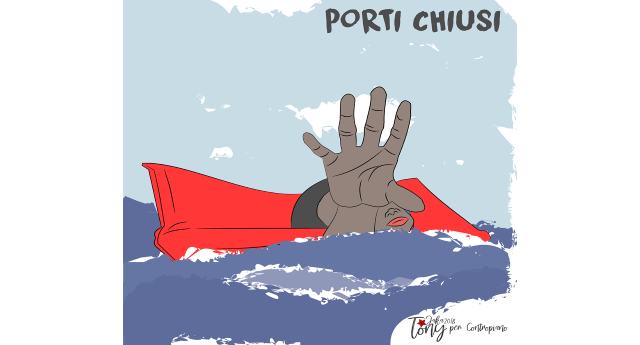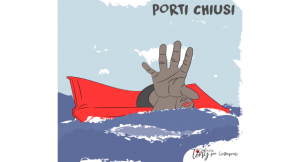.
seguiteci sulla pagina Facebook Curiosity
.
.
Amarcord – Il 15 giugno 1966 andava in onda per la prima volta “Belfagor – il fantasma del Louvre”. Lo sceneggiato fu poi replicato varie volte, nel 1969, 1975 e 1988, “terrorizzando” i ragazzini di più generazioni…
I bambini degli anni ’60 e ’70 non hanno paura di niente, tranne che del fantasma nero di Belfagor che scivola di notte tra le sale del Louvre …
Era il 15 giugno del ’66 quando andò in onda sul secondo canale della Rai la prima puntata di ‘Belfagor ovvero il fantasma dei Louvre‘. E da quella sera, per sei puntate, milioni di famiglie italiane restarono incollate davanti alla Tv ipnotizzate da quell’insolito sceneggiato francese in 4 puntate, in cui una misteriosa gura nera si aggirava di notte per le sale deserte dei Louvre. E fra tutto questo pubblico c’eravamo noi, i bambini, affascinati dalla storia misteriosa che ci veniva raccontata e terrorizzati dalle fugaci apparizioni di quella maschera dorata dagli occhi enormi e dal lungo mantello scuro.
Belfagor ovvero il fantasma dei Louvre è una storia in bilico tra giallo e horror fantastico, che in Francia fu replicata solo due volte, ma che in Italia – a grande richiesta – la RAI rimandò di nuovo in onda nel ’66, nel ’69, nel ’75 e infine su Raitre nell’88. I dialoghi sono asciutti, la fotografia è ‘espressionista‘, sullo sfondo una Parigi esistenzialista in bianco e nero, dove si muovono personaggi simbolo di quell’epoca come Juliette Gréco nel ruolo di Luciana Borel. Tra gli altri interpreti compaiono René Dary nel ruolo dei commissario, e Andrea Bellegarde.
Tutti coinvolti in un mistero che comincia con l’omicidio di un guardiano dei Louvre. Le indagini, condotte dall’ispettore Menardier, portano all’attività di un gruppo di occultisti che si ispirano a un’antica società segreta, quella dei Rosacroce, il cui tesoro sarebbe nascosto nel Louvre. Tra i membri della confraternita ci sono Lady Hodwyn, l’affascinante Luciana Borel, la sua gemella Stefania e Boris Williams, dotato di un’oscura forza ipnotica. Sarà lui con i suoi poteri a trasformare Luciana in Belfagor e a spingerla al suicidio finale
C’è un fantasma nel Louvre… Un fantasma si aggira per l’inconscio di chi ha almeno 45 anni. Non so quanto possa dire questo post agli under 40. Non dico che non abbiano mai sentito parlare di Belfagor ma l’aver vissuto la cosa è sicuramente diverso. Se vi dicessi che ancora oggi, se devo percorrere un corridoio buio anche in casa mia lo faccio regolarmente di corsa senza guardarmi indietro? Colpa di Belfagor. Da qualche parte devo avere ancora qualcuno dei disegni che facevo compulsivamente per esorcizzare lo spavento: Belfagor di qui, di là, di fianco alla casetta con l’alberello, Belfagor piccolo, Belfagor grande. Mio nonno me li comperava, 100 lire l’uno (che a pensarci oggi era una bella cifra!) Ma chi era ‘sto Belfagor? Il 15 giugno 1966 sul Secondo canale della televisione (allora c’era solo la RAI) andava in onda per la prima volta uno sceneggiato francese in sei puntate, “Belfagor o il fantasma del Louvre” ispirato a un romanzo scritto nel 1927 da Arthur Bernède e diretto da Claude Barma. Lo sceneggiato fu poi replicato varie volte, nel 1966, 1969, 1975 e 1988. La Francia era molto popolare in televisione allora. Un anno prima avevano cominciato ad andare in onda “Le Inchieste del Commissario Maigret” con Gino Cervi e la collaborazione alla sceneggiatura del maestro Camilleri. Tutto rigorosamente in bianco e nero. Belfagor fu una sferzata in faccia. Sugli allora pudibondi schermi democristiani approdarono tutti assieme: i Rosa Croce e le sette segrete, l’esoterismo, l’alchimia, l’antico Egitto, una donna adulta che ha una relazione con uno studentello, le droghe che rendono gli individui automi, i maestri del terrore e misteriose pietre radioattive, il tutto avvolto in una pericolosa nebbia sulfurea e diabolica (Belfagor è un famoso arcidiavolo). Ricordo la trama per i troppo giovani. Un guardiano del Museo parigino del Louvre viene assassinato nottetempo durante il suo giro di ronda. Il commissario Menardier indaga e per conto suo anche uno studente curioso, Andrea Bellegarde, che si fa prendere dal mistero che circonda il caso. Già, perché si parla di un misterioso fantasma che si aggirerebbe nelle sale dell’Antico Egitto, visto da diversi guardiani. Andrea, che ha conosciuto per caso Colette, la figlia del commissario, si fa rinchiudere nel Louvre assieme a lei che ha ereditato il fiuto da segugio dal padre e una notte il fantasma compare finalmente. E’ alto, completamente ricoperto da un mantello nero e indossa una maschera di cuoio. Nel corso delle indagini Andrea conosce Luciana, un’affascinante signora dell’alta borghesia che ha una relazione con un misterioso individuo, un certo Williams. Da lì la trama si sviluppa e si fa intricatissima. Compaiono una vecchia signora che forse sa troppe cose, una setta esoterica e una sorella gemella di Luciana. Chi è il fantasma? Chi manipola la sua volontà? Elemento fondamentale del successo di Belfagor era la sceneggiatura di Jacques Armand che mescolava tutti gli elementi della storia misteriosa senza far uso di effetti speciali o trucchi. Lo spavento nasceva da cose in fondo stupide ma tremendamente efficaci. Cosa immaginare di più spaventoso che svegliarsi nella propria camera con Belfagor che si nasconde dietro una tenda? Un altro elemento di fascinazione è la Parigi di Belfagor, che è ancora quella dei cafés, dei cancan e delle edicole, un luogo denso di grandi misteri ma in fondo familiare. In Belfagor domina la presenza magnetica di Juliette Greco, con la voce profonda, l’occhio egizio e l’allure di femme fatale. Assieme a lei il protagonista Yves Rénier, deciso a combattere il male ma manipolato e salvato da figure femminili di grande forza. Nei ruolo secondari René Dary, visto in “Non toccate il Grisbi”, un commissario Menardier con gli accenti di un Gabin, mentre François Chaumette conferma la sua grandezza di attore teatrale. Una curiosità, nei panni eburnei di Belfagor si celava un mimo, Isaac Alvarez.